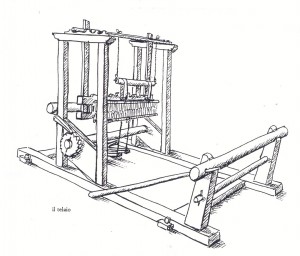di Filippo Curtosi
Giuseppe Zigaina è un pittore che abita a Cervignano del Friuli in una bella villa bianca ad un solo piano che si trova in ogni guida che si rispetti dell’architettura italiana contemporanea,opera dell’architetto Giancarlo De Carlo, padre dello scrittore Andrea. Zigaina è stato intimo amico di Pier Paolo Pasolini e 40 anni fa si faceva cinquanta chilometri in bicicletta per venire dall’amico a parlare di Freud. Si erano conosciuti ad Udine nel 1946 a una mostra collettiva di pittura. Pasolini, dice Zingania a Camillo Langone che lo intervista per “Il Foglio” dipingeva molto bene. Nel 1950 Pasolini se la passava malissimo, disoccupato a Roma con la pena della madre costretta a fare la donna di servizio, lei che in Friuli era maestra e soprattutto moglie di un ufficiale di sangue blu. Fu proprio davanti al prato verde della villa di Zigania che Pasolini regalò a Maria callas un anello che lei credette di fidanzamento.

Dozzine di biografi, continua Langone non sono riusciti a scrivere nemmeno una riga sulla questione araldica del regista che avrebbe potuto atteggiarsi a conte Pasolini Dall’Onda, patrizio di Ravenna. Se evitò di farlo è perché doveva vendere libri e non bottiglie di vino. Nel mondo del vino lo stemma tira sempre molto,in quello letterario costituisce un passaporto per il ridicolo. Langone poi chiede con insistenza al vecchio pittore: Pasolini c’è stato o non c’è stato con la Callas? Cosa successe su questo prato 50 anni fa? Zigaina però tende a divagare. In verità al vecchio amico dello scrittore interessa più la morte. Secondo lui Pasolini scelse, l’anno, il mese, il giorno ed il luogo della propria morte. Pasolini non è più quello degli anni 50-60 che faceva contorsionismi per non tradire la memoria del fratello partigiano ucciso dai comunisti. Il Pasolini del ’74 scrive Langone è ormai apertamente di destra. Lo scrive lui stesso, ma nessuno lo legge.
Il tempo corre davvero in fretta, se è vero che sono già trascorsi trentacinque anni dalla morte che il 2 novembre del 1975 colpi Pasolini e l’intera cultura italiana. Lo scrittore venne trovato ucciso in uno spazio periferico presso Fiumicino tra baracche e rifiuti.
Nel suo correre in fretta il tempo rischia di portarsi via anche i fatti più rilevanti permettendo, a chi si cimenta con le ricorrenze, di fornire una versione in parte distorta e in parte oleografica di un uomo che meriterebbe invece ben altra considerazione.
E’ stato così purtroppo per quasi tutti coloro che hanno scritto su Pasolini e su quella tragica giornata riproponendoci tante favole. Lui, ne “Il romanzo delle stragi” diceva:
“Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia, il mistero”.
La scomparsa di Pier Paolo Pasolini, non è la scomparsa di un intellettuale, di uno scrittore qualsiasi, ma la scomparsa di una storia, di una generazione di uomini e di Poeti militanti che, con il proprio operato hanno segnato un pezzo importante di storia politica e culturale del nostro Paese. Se ne è andato davvero un pezzo importante del Novecento democratico di questo paese.
Certo si rischia di essere retorici ricordando una stagione che adesso sentiamo davvero tramontata con Pier Paolo Pasolini, specialmente chi come noi giovani studenti hanno avuto la fortuna di ascoltarlo in qualche bar di Monteverde assieme a Ninetto Davoli. Poeta, scrittore, regista, giornalista prestigioso ed inquieto. Molte cose sono state scritte e saranno scritte in futuro su di lui. La cultura del secolo scorso è stata notevolmente influenzata dal pensiero di Pier Paolo Pasolini: dallo scontro tra passione e ideologia, tra neocapitalismo corruttore e desistenza rivoluzionaria, queste sono le battaglie contro e senza speranza in quanto sosteneva che il dissidio tra religiosità e marxisismo porta alla separazione.
Con Pasolini si poteva discutere tutto e si poteva dire tutto perché era un uomo di grande statura morale. Certa stampa lo ha voluto trascinare da una parte all’altra e quasi sempre lo ha classificato di sinistra e questo per la verità è falso perché fu severo con la sinistra ufficiale del tempo: raccontava storie di miserie che al senso della pietà cristiana affiancava la dimensione della tragedia esistenziale, questo si: una penna libera e sapiente come quella di Barbara Spinelli ricorda di Pasolini molte virtù: “i lavori poetici e cinematografici, la libertà, i pensieri profondi sulla guerra, sulla crisi delle democrazie, sull’imprescindibile dialettica fra destra e sinistra. Ancora i giudizi rigorosi sulla peculiare decadenza delle istituzioni repubblicane: decadenza appunto che a parere di Pasolini era cominciata negli anni ‘60 con l’avvento di quel nuovo centrosinistra, che si alimentava di “ democrazia” dell’applauso.
PASOLINI IN CALABRIA
Verso la metà degli anni Settanta, Pasolini si mise di buona lena a lavorare alla realizzazione di un film liberamente ispirato a “Il Vangelo”. Cominciò a viaggiare per i paesi più sperduti dello stivale alla ricerca di “facce” primitive, giovani, insomma quei volti di attori non professionisti che poi diventavano protagonisti nei suoi memorabili film. Così lo scrittore, giungendo verso l’autunno del ’73 nel meridione d’Italia, passa per la Calabria, prima di approdare in Sicilia alla ricerca di attori e di luoghi per ambientarvi qualche scena,osserva una regione a pezzi.” Giovani impazziti, o ebeti o nevrotici-annota il regista-poeta e scrittore nel suo diario di lavoro-vagano per le strade del Sud coi capelli irti, le sagome deformate dei calzoni che stanno bene solo agli americani: vagano con aria soddisfatta, provocatoria, come se fossero depositari del nuovo sapere. Sono in realtà, paghi dell’imitazione perfetta del modello di un’altra cultura. Hanno perso la propria morale e la loro arcaica ferocia si manifesta senza forma. Un mutamento antropologico arrivato a rilento ha traviato la sana cultura popolare, tollerante e rispettosa della socialità e della diversità, inoculandole il virus dell’egoismo individualista e del perbenismo ipocrita..quel piccolo mondo di Sodomia è stato distrutto da una Gomorra feroce ricalcata su Milano…il modello del centro-propagato dalla televisione-non è raggiungibile da un ragazzo calabrese che vede cosi aumentare il suo tratto di inferiorità, facendolo precipitare nell’ignoranza sino alla ebetitudine”. A Vibo Valentia ebbe la dimostrazione pratica di queste convinzioni.
Parlando con gli studenti del Liceo Classico “Morelli”, un gruppetto di studenti tentò di aggredire il regista, così come al “Circolo del Cinema”, inventato dal mio amico regista Andrea Frezza che all’epoca frequentava il centro sperimentale di cinematografia a Roma o ancora nella libreria di Pino Mobilio – lo ricordo come se fosse ora presente – lo faceva scandalizzando. L’avevo conosciuto alla facoltà di Lettere della “Sapienza”, dove teneva una “Lectio magistralis” assieme ad Alberto Moravia. Gli regalai “la Ceceide” di Vincenzo Ammirà che lui già conosceva. Mi ringrazio’ aggiungendo che di Ammirà gli interessava il suo profilo morale dell’uomo, perché oltre ad essere un grande poeta dialettale, fu uno spirito inquieto e rivoluzionario vero come lo sanno essere solo i veri calabresi”. Racconta Nando Scarmozzino sulla rivista “Rogerius: “tra i presenti nella libreria c’era anche Mimmo Mobilio in quel periodo insegnante a Piani di Acquaro che informò lo scrittore di un fatto successo ad Ariola in quei giorni: durante un funerale era caduta la bara e la salma era finita in un burrone dove passava una fiumara. Fu anche detto a Pasolini che gli abitanti di Ariola, quasi tutti contadini erano costretti a vivere in condizioni umilianti in uno stato di isolamento drammatico. Pasolini ascoltò con attenzione e accettò di fare visita in quel posto. Ci fu un incontro pubblico ed il poeta promise che avrebbe mandato un contributo per costruire un ponte. I soldi arrivarono e furono affidati a Bruno Mamone, oggi emigrato in Australia per fare qualcosa. Di questa visita vibonese ha scritto Sharo Gambino su “Quaderni Calabresi” un pezzo dal titolo: “I Marcusiani dell’Ariola”. Dopo Ariola, Pasolini raggiunse Serra San Bruno e si intrattenne “ferocemente” con i certosini del luogo in uno scambio di vedute senza esclusioni di colpi. Ma il vero colpo giornalistico lo mette a segno Franco Santopolo direttore de “Il Manifesto”, con una intervista esclusiva nel numero unico dell’Aprile del 1964, in redazione tra gli altri figuravano Marcello Furriolo, Nuccio Marullo, Franco Presterà e Nicola Ventura. L’occasione fu la consegna del premio letterario “Città di Crotone”, allorché gli venne revocato il premio precedentemente assegnatogli per il Romanzo “Ragazzi di vita” in seguito ad alcune dichiarazioni che vennero ritenute offensive per la nostra terra. “Dopo averci presentato la sua illustre compagna, la scrittrice Elsa Morante, scrive Marcello Furriolo, ci dichiara: “Sono in Calabria per trovare dei volti nuovi per il mio prossimo film Il VANGELO, di cui inizierò le riprese a Roma e a Tivoli, per poi trasferirmi in Puglia, Lucania e quindi verso la fine di Maggio in Calabria nelle zone di Cutro, Crotone e nel vibonese. Il paesaggio calabrese con i suoi meravigliosi contrasti naturali in cui a dolci pendii si contrappongono violenti sbalzi rocciosi penso che sia determinante e quindi essenziale per il mio film”. Non avrà, incalza Furriolo, anche dei motivi di carattere sociale? “Penso che le folle colorite e varie che si incontrano in queste zone,difficilmente si trovino altrove.Ecco,è proprio il senso dei luoghi:la bellezza di queste masse che io voglio sfruttare per il mio film”. Cosa pensa, domanda il giornalista de “Il Manifesto” della città di Catanzaro? “Sono stato più volte a Catanzaro ed ho avuto sempre la stessa sensazione. Catanzaro come tutte le città burocratiche è una città un po’ triste e deprimente. Infatti malgrado si trovi in un posto molto bello e piacevole, la carenza di uno sviluppo urbanistico organico, per la mancanza di un Piano regolatore le conferisce un aspetto un po’ caotico e confusionario, ma sempre grigio ed amorfo, cosa che del resto avviene in moltissime città italiane. Non credo che possa considerarsi vita e quindi vivacità un certo tipo di società medio borghese, in cui i problemi, le ansie, le attività nascono dalle preoccupazioni individuali egoistiche di una grigia classe impiegatizia che purtroppo per voi costituisce il nervo di questa enorme impalcatura burocratica. Penso che si possa parlare di vivacità e quindi di vita, in quelle città marinare, mercantili, laddove si sente palpitare il cuore delle masse popolari. Quello che Pasolini diceva, lo si poteva stampare, rigo per rigo; la sua cultura e la sua dirittura politica, poetica e filosofica, erano tali che ognuno doveva fare conti con lui. Non vi è dubbio che nel multiforme complesso della produzione di Pasolini la sua “dottrina” politica segna nel modo più spiccato l’originalità non solo dello scrittore ma dell’uomo.
Poesie, lettere, polemiche, interventi nel dibattito politico e culturale di quegli anni. Nico Naldini, suo cugino scrittore, nella sua biografia cosi scriveva: “La figura pubblica di Pasolini che si è andata via via costruendo, anche contro i suoi desideri, continua ad esporlo ad ogni sorta di attacchi, dai quali non si ripara mai, anzi egli stesso li provoca con insistenza. Sia che si tratti di un dibattito su un libro o della presentazione di un film, scende dalla cattedra per controbattere con lucidità ossessiva le provocazioni di quella parte del pubblico che lo confuta con un delirio di tensioni e di violenza. Qualsiasi occasione basta scatenare l’aggressività di questo pubblico”.
Nel suo diario di venticinquenne, Naldini annota: “La mia mostruosità nell’amare T”.
T., stava per Tonuti Antonio. “L’omosessualità è un’orrenda malattia” dice Zingania.
Lo diceva anche lui.
Gian Carlo Ferretti, curatore dei “Dialoghi 1960-65” ci parla di un intellettuale carismatico, un autore trasgressivo, un bersaglio predestinato dai suoi scritti, dai sui comportamenti pratici e dall’accettazione consapevole del rischio, lo scenario di quella notte… un delitto omosessuale o politico che rimanda ad un clima persecutorio. La morte di Pasolini diventa, conclude Ferretti, soltanto l’ultimo tragico episodio di quella lunga vicenda, nel pieno della stagione di massima sfida e di massimo rischi.
Pasolini ha concepito e organizzato la sua morte come un linguaggio destinato a incrementare di senso la sua opera. In una poesia pubblicata nel ’64: “Sul vecchio litorale/ tra ruderi di antiche civiltà/Ravenna/Ostia o Bombay- è uguale/comincerò pian piano a decompormi/ nella luce straziante di quel mare”.
Sceglierà Ostia che deriva da “ostia” vittima sacrificale, laddove in antico si compivano sacrifici umani. Scelse infine una data sacra, una Domenica dei Morti, facendone un oscure accenno nella poesia intitolata “Patmos”. La Callas riuscì a posticiparne il triste epilogo. Mori infatti il giorno dei Morti, ma non di domenica.
Il 2 Novembre la morte, poi il funerale: Campo de’ Fiori con le bandiere rosse ed il discorso di Alberto Moravia che dice: “Era un grande poeta civile e non ne nascono tanti in un secolo”.





 La vera cultura”, sostiene lo scrittore Juan Manuel de Prada, è quella che nasce da ciò che i romantici tedeschi chiamavano Volkgeist, “lo spirito del popolo”; deve essere una emanazione naturale della gente, che canta, balla, racconta, dipinge, perché sente il bisogno di esprimere qualcosa che le appartiene nel profondo, qualcosa che è legato alla sua genealogia spirituale alla sua identità. Questa cultura, oggi come ieri, subisce però il sequestro da parte del potere; quest’ultimo si rende conto che se riesce a trasformare queste effusioni naturali in un”artefatto”, ossia in un prodotto artificiosamente creato, può ottenere una ingegneria sociale. Allo stesso tempo si osserva una casta di intellettuali gregari; persone che si sono adeguate a una determinata interpretazione della realtà auspicata dal potere, che le sovvenziona e promuove, affinché impongono una determinata cultura,che non è autentica, perché non nasce da una espressione naturale del popolo. Inoltre, all’idea di popolo si è andato sostituendo il concetto nuovo di “cittadinanza”, una massa amorfa dove l’esperienza artistica non si produce più in modo naturale.
La vera cultura”, sostiene lo scrittore Juan Manuel de Prada, è quella che nasce da ciò che i romantici tedeschi chiamavano Volkgeist, “lo spirito del popolo”; deve essere una emanazione naturale della gente, che canta, balla, racconta, dipinge, perché sente il bisogno di esprimere qualcosa che le appartiene nel profondo, qualcosa che è legato alla sua genealogia spirituale alla sua identità. Questa cultura, oggi come ieri, subisce però il sequestro da parte del potere; quest’ultimo si rende conto che se riesce a trasformare queste effusioni naturali in un”artefatto”, ossia in un prodotto artificiosamente creato, può ottenere una ingegneria sociale. Allo stesso tempo si osserva una casta di intellettuali gregari; persone che si sono adeguate a una determinata interpretazione della realtà auspicata dal potere, che le sovvenziona e promuove, affinché impongono una determinata cultura,che non è autentica, perché non nasce da una espressione naturale del popolo. Inoltre, all’idea di popolo si è andato sostituendo il concetto nuovo di “cittadinanza”, una massa amorfa dove l’esperienza artistica non si produce più in modo naturale.